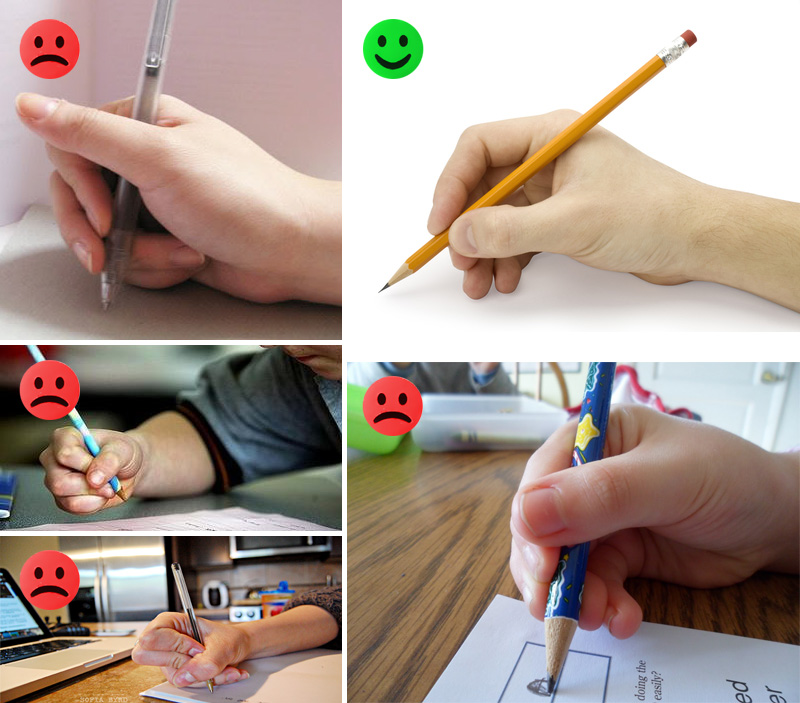In una società ricca di benessere Alimentare, ci si ritrova spesso in diatribe su quale sia l'Alimentazione migliore, ed ecco che i media ci bombardano di pubblicità, le riviste propongono miracoli con le diete last minute e nei talk show avvengono scontri inverosimili tra specialisti e presunti tali che spingono gli ascoltatori verso l'uno o l'altro versante come fossero schieramenti politici.
Ma in tutto questo marasma c'è chi vive uno strano rapporto col cibo a tal punto da esserne proprio ossessionato!
Nel mondo dei disturbi alimentati accanto alle patologie più note come Anoressia, Bulimia ed Obesità, vi sono una serie di disturbi di cui ancora non se ne parla o se ne parla poco!
Attualmente sta emergendo un nuovo tipo di disordine alimentare l' Ortoressia.
Mentre nell'anoressia il paziente rifiuta di nutrirsi, nella bulimia si riscontrano frequenti abbuffate con vomito indotto, nell'Ortoressia vi è un'Ossessione per la ricerca del cibo sano.
Vi domanderete, e cosa c'è di strano a voler mangiare cibi sani?
Nulla! Ma quando la ricerca diventa un'ossessione e influisce sulla nostra vita quotidiana, può rappresentare un problema!Cos'è dunque l'Ortoressia?
E' una forma di attenzione eccessiva alle regole alimentari, alla scelta del cibo e alle sue caratteristiche che può emergere da una paura smisurata e a volte maniacale, di ingrassare o di non essere in perfetta salute, vi è la credenza che i cibi non siano sani o siano contaminati. Tali convinzioni alimentano la comparsa di un vero disagio alimentare con conseguenti problematiche socio-relazionali e di vita quotidiana.L'ortoressico inoltre, impiega un tempo via via sempre più lungo nella ricerca di un modo per rimanere aderente al regime alimentare che si è imposto ed è costretto a pianificare i pasti con diversi giorni d'anticipo! Inoltre quando esce, tende a portare con sè un "kit di sopravvivenza" con il proprio cibo perchè non può alimentarsi con pietanze preparate da altri.
Secondo i dati del Ministero Italiano della Salute per i disturbi alimentari, le persone affette da Ortoressia sarebbero 300 mila in Italia con una prevalenza di uomini (Donini e coll. 2004).
la maggior diffusione nel sesso maschile può essere ricondotta al proliferarsi di stereotipi culturali legati alla forma fisica e trova un parallelismo nella corrispondente diffusione della Virgoressia (ovvero una preoccupazione cronica di non avere un corpo sufficientemente muscoloso).
Quali sono le caratteristiche dell'Ortoressia?
- Ruminazione ossessiva sul cibo (più di 3-4 ore al giorno pensare a quali cibi scegliere)
- pianificazione dei pasti con diversi giorni di anticipo
- impiego di molto tempo per la ricerca e l'acquisto degli alimenti
- preparazione del cibo solo in certi tipi di stoviglie e con cotture particolari
- insoddisfazione affettiva e isolamento legata al mantenimento di queste regole rigide
Si ripercuote negativamente non solo sul benessere emotivo e sociale, ma vi sono conseguenze evidenti sul benessere del corpo: osteoporosi, atrofie muscolari, squilibri elettrolitici che spesso necessitano di interventi di ospedalizzazione.
Spesso l'ossessione del cibo è anche associata ad un'ossessione per la pulizia, esercizio fisico, cure estetiche ecc.
A Livello Psicologico insorgono dei comportamenti tipici dell'ossessivo compulsivo, inoltre la persona che ne è affetta vive un perenne stato d'ansia e timore per tutti i problemi che il contatto con il cibo non sano potrebbero causargli. Allo stesso tempo, può mostrare transitori momenti di euforia quando riesce a resistere alle tentazioni. mentre fenomeni depressivi e sensi di colpa possono celarsi quando ricompaiono lo stato d'ansia e il nervosismo.
Come si cura?
Il trattamento dovrebbe avvalersi di un'equipe multidisciplinare composta da psicoterapeuti, medici e nutrizionisti/dietisti, attraverso un'azione integrata tra il paziente e la famiglia.Un trattamento efficace dev'essere condotto gradualmente, ed è necessario lavorare sulle emozioni e sulla reintroduzione dei comportamenti alimentari eliminati, puntando anche su eventuali malesseri fisici causati da una dieta squilibrata!